Le radici di un libro. Debiti e genealogie.
Diceva sempre Giampiero Bof, con bella ironia: “Spesso le nostre idee più originali non sono altro che citazioni di cui abbiamo dimenticato la fonte”. Così in un libro, che pure ha per necessità una serie di “note”, bisogna chiarire bene, o almeno il più possibile, tutti i debiti verso persone, verso luoghi e verso testi molteplici e disparati, che sfuggono ad una visione davvero esauriente. Così, all’inizio del mio manuale sulla Eucaristia, ho voluto mettere questa “Prefazione”, nella quale chiarisco alcune idee, rivelandone le fonti e le relazioni da cui scaturiscono. Ecco allora la Prefazione, che si trova alle pagine 5-8 del testo e che qui riporto, come un “assaggio” del testo.
PREFAZIONE
“La Liturgia è una cosa viva, ma fragile; muore nelle mani
di chi non la sa trattare. 2) La Liturgia è una cosa viva,
ma solo se è dinamica, volta cioè verso l’avvenire, con
l’avvertenza che il suo dinamismo è tra due poli: quello
del mistero di salvezza realizzato da Cristo e quello dello
stesso mistero di salvezza da realizzarsi in noi”
(Salvatore Marsili)
La lunghissima gestazione di questo manuale – durata quasi vent’anni
– corrisponde al travaglio di una proposta teorica plausibile, dovuta alla
esigenza di pensare la “forma” del sacramento dell’eucaristia in modo
profondamente rinnovato. L’urgenza di una sintesi sistematica, che fosse
adeguata alla nuova esperienza liturgica dell’eucaristia – dischiusa prima
dal Movimento liturgico e poi dal concilio Vaticano II e dalla riforma
liturgica che ne è coerentemente scaturita, senza alcuna nostalgia verso
le forme rituali del passato – mi ha sollecitato non solo ad una radicale
comprensione delle rinnovate azioni liturgiche della celebrazione eucaristica, ma anche ad una profonda revisione delle categorie sistematiche di interpretazione della tradizione, senza la cui accurata traduzione in termini nuovi ogni riforma sarebbe destinata a spegnersi di certo nel giro di poche generazioni. Molti sono i debiti che devo qui ricordare, con grande riconoscenza, per il sorgere stesso di questa ipotesi di comprensione del sacramento dell’eucaristia.
Anzitutto, e in forma generale, la vocazione allo studio e all’insegnamento,
che prima l’Istituto di liturgia pastorale «S. Giustina» di Padova e poi il Pontificio Ateneo «S. Anselmo» di Roma hanno rispettivamente
inaugurato e sostenuto. Il mio impatto con l’ambiente monastico e accademico dell’Abbazia di S. Giustina, con la sua accoglienza
nei ritmi e nelle forme, nella ricerca e nel confronto, è iniziato
nel 1988 – per iniziativa generosa, e quasi in contropiede, di Giampiero
Bof – e ha segnato questi trent’anni con una “conversione alla liturgia”
che ha profondamente mutato le mie priorità, il modo di formulare le
mie domande e la maniera di trovare le mie risposte. L’incontro con
docenti come Pelagio Visentin, Alceste Catella, Giorgio Bonaccorso,
Aldo Natale Terrin, Roberto Tagliaferri, insieme a Gianni Cavagnoli,
a Franco Brovelli, a Giuseppe Zanon e al grande Luigi Sartori – con
l’accompagnamento benedetto e benedettino di una efficace presenza
anselmiana a Padova, prima di Magnus Loehrer, poi di Benno Malfèr
e infine di Elmar Salmann – ha suscitato in me una domanda su tutti i
riti e in particolare sul rito cristiano per eccellenza, sull’eucaristia, che
perdura inalterata.
Il percorso prima di formazione e poi di insegnamento in quell’ambiente
ha strutturato una mens di attenzione alla liturgia che ha fatto
emergere in me nuove esigenze di lettura della teologia eucaristica. Il
corso sull’eucaristia che da venticinque anni tengo, ogni tre anni, presso
l’Ateneo anselmiano, insieme al corso di introduzione alla liturgia che
tengo ad anni alterni a Padova, e ogni anno per il corso del triennio
presso l’Augustinianum-Marianum a Roma, sono stati i “primi motori”
del mio pensiero specifico sul sacramento della comunione. Di grande
importanza è stato, quasi vent’anni fa, il lavoro di cura, insieme ai cari
colleghi Pius Ramon Tragan e Marinella Perroni, del Corso di teologia sacramentaria, edito da Queriniana, che aveva, nel suo centro sistematico,
proprio il sacramento dell’eucaristia. Ma accanto a ciò, le innumerevoli
messe celebrate nei diversi luoghi della mia esperienza di cristiano cattolico
– a Savona, anzitutto, la parrocchia di S. Rita (dove era la mia casa)
e quella di S. Giuseppe (dove era la casa dei miei nonni), la cappella di
S. Raffaele al porto (con don Mario e don Bof), le parrocchie del Sacro
Cuore (con don Delfino) e di S. Dalmazio (con don Lupino), la chiesetta
di Casa Zaccheo (con don Lello) e la parrocchia di S. Filippo Neri (con
don Riccardo e don Agostino); inoltre, l’Abbazia di S. Giustina a Padova,
la parrocchia di S. Andrea a Sommacampagna, quella di S. Pietro in
Bevagna sulla costa ionica e di S. Pietro a Modica, i diversi monasteri nei
quali sono stato ospitato per lezioni e conferenze, come quelli di Castel
Madama, Grandate, Lovere, S. Agata Feltria, Camaldoli, La Pierre qui
vire, Pian del Levro, Pannonhalma, Pra d’Mill, S. Antonio sull’Aventino e la vivace comunità di Montebelluna, insieme con le diverse parrocchie in cui
sono stato o sono passato, per conferenze o interventi. Tutto questo ha
messo in moto e ha arricchito di esperienza una riflessione e una pratica,
che si sono articolate e arricchite a vicenda, sollecitate dalla grande
riscoperta liturgica, ma anche interessate ad onorare, da sempre, l’inaggirabile compito sistematico che compete alla teologia. Così, alla ricerca di modelli di soluzione di questo iniziale imbarazzo, mi sono imbattuto in alcuni grandi testi, spesso incontrati grazie alla previa conoscenza e frequentazione dei loro autori. Così Eucaristia. Il pasto e la parola di Ghislain Lafont, la voce Eucaristia di Alceste Catella del dizionario Teologia, il volumetto Celebrare la salvezza. Lineamenti di liturgia di Giorgio Bonaccorso sono diventati per lungo tratto le “stelle polari” del mio
sapere eucaristico, senza trascurare gli apporti fondamentali e classici di
Romano Guardini e Joseph Andreas Jungmann, di Salvatore Marsili e
di Enrico Mazza. Più di recente ho scoperto la pregevole sintesi offerta
dal volume Die Messe di Johannes H. Emminghaus, al quale debbo la
impostazione di fondo di questo manuale, sia pure da me ripensata anche
secondo diversi criteri e priorità ulteriori. A tutti questi interlocutori
reali e virtuali, attuali o passati, va il mio grazie riconoscente.
Debbo inoltre precisare che questo manuale, come apparirà anche
dall’uso delle citazioni, si lascia ispirare naturalmente dalla teologia eucaristica elaborata soprattutto nel lavoro accademico ed ecclesiale italiano, che è vasto, articolato e non è mai stato soltanto romano. L’Italia,
come comunità cristiana, come chiesa, ha saputo esprimere negli ultimi
decenni una teologia liturgica di alta qualità e dai tratti assai originali
nel panorama europeo e mondiale. In un certo senso, la struttura stessa
di questo manuale è il frutto del grande lavoro che sul piano liturgico,
storico e sistematico hanno proposto alla attenzione i teologi italiani
delle ultime quattro generazioni: da Cipriano Vagaggini a Zeno Carra,
da Salvatore Marsili a Ubaldo Cortoni, da Pelagio Visentin a Pierpaolo
Caspani, da Emanuele Caronti a Manuel Belli. La distanza biografica
tra questi ultimi due teologi è esattamente lo spazio di un secolo; uno
era nato nel 1882, l’altro è nato nel 1982. Così la penultima generazione
di teologi – alla quale appartengo – può guardare con una certa possibilità
di sintesi al grande lavoro delle due precedenti e a quello della
generazione successiva, che è appena iniziato ma già dà frutti nuovi e
promettenti.
Spero che questo volume possa svolgere la funzione di accompagnare
studenti e cultori all’interno del mondo del sacramento dell’eucaristia
e nel rito della messa, dando loro alcune coordinate per fare discernimento,
tanto della tradizione comune, quanto della loro personale
esperienza. Se ciò avverrà almeno in parte, ne sarà valsa la fatica.
Dedico il volume a due miei grandi maestri: Giampiero Bof, prete
savonese e teologo di razza che “pensava parlando”, con rigore e profondità,
nelle lezioni e nelle omelie, nelle conferenze e nelle divagazioni
musicali o culinarie, e che mi ha accompagnato per quarant’anni, fin dal
lontano 1978; e Benno Malfèr, professore, abate benedettino e lucidissimo
pensatore, sempre a cavallo tra mondo germanofono e italofono,
che conobbi più di vent’anni dopo, a Padova. Sono scomparsi entrambi
poco più di un anno fa, a circa tre mesi di distanza uno dall’altro. Essi
mi hanno mostrato con l’esempio – di vita e di dottrina – come si possa
costruire un sapere teologico serio, insieme onesto e audace, che aspiri
ad essere convincente e credibile, permettendo a sé – ma più spesso
esigendo da sé – una grande libertà. A loro va un grato e commosso
ricordo, pieno di riconoscenza e di ammirazione. Solo con la loro morte,
improvvisa e triste, mi sono definitivamente risolto a scrivere questo
volume: quasi a dar voce a ciò che da loro avevo appreso in lunghi anni
di fecondo apprendistato. Con Giampiero, in lunghissime discussioni
durante i frequenti viaggi in automobile per tutt’Italia, dagli anni Ottanta
fino agli inizi degli anni Duemila, verso appassionanti congressi
teologici; con Benno, in intense sedute di lavoro a Roma, a Padova, a
Bolzano e a Montserrat, nelle quali i lunghi silenzi erano tanto importanti
quanto le parole misurate e illuminanti. Tutto questo bagaglio di
esperienze e di pensieri, di esistenze e di resistenze, ora deve essere
custodito e trasmesso anche ad altri, nella logica più autentica di ciò
che siamo abituati – ma anche autorizzati – a chiamare “tradizione”.
Savona, 22 maggio 2019





























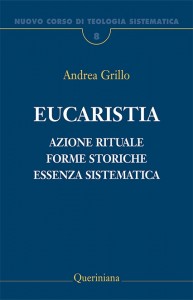
 Area personale
Area personale












Carissimo prof. Andrea,
è da tempo che non ci sentiamo o vediamo. Sono accadute molte cose. Se Dio ci concederà di incontrarci racconteremo reciprocamente i nostri trascorsi. Intanto spero che tu stia bene.
Oso farmi sentire per ringraziarti di questo libro che sono sicuro sarà molto utilizzato nella formazione teologica. Dall’indice che ho potuto leggere dal sito della Queriniana posso dire che a me piace. Certo, non sono un’autorita’ ma anche i pareri “periferici” saranno per te importanti.
C’era bisogno di un manuale su un singolo sacramento che raccogliesse il lavoro della seconda svolta antropologica e del genere ritus. È come se offrissi a noi studenti un nuovo corso su ciò che hai insegnato nel campo della generale.
Grazie perché non ti sei fermato in questi anni a ripetere il bagaglio culturale accumulatosi. A volte ti ho seguito, altre meno. Ciò che importa è la tua passione teologica contagiosa.
Farò conoscere questo testo anche a don Pasquale Cascio che alla sua diocesi di Sant’Angelo da quest’anno ha chiesto di fermarsi sull’eucaristia.
Intanto ti saluto impegnandomi ancora di un pensiero orante per te. Altrettanto spero possa fare per me. A presto
Caro Don Antonio, ti sono grato per questo commento. Ti sento presto. Un caro saluto
Andrea