Donne e ordine: S. Tommaso d’Aquino nel magistero (/2), di Riccardo Saccenti
Donne e ordine. Note sull’uso di Tommaso d’Aquino nei documenti del magistero. 2: Storia e metodo della teologia di Tommaso
di Riccardo Saccenti
Le due brevi citazioni del Commento alle Sentenze utilizzate in Inter insigniores appartengono alla più generale discussione riguardo all’ordine che si sviluppa nel commento della distinzione venticinquesima del quarto libro delle Sentenze di Pietro Lombardo. Una circostanza, questa, che suggerisce di richiamare brevemente le caratteristiche storico-letterarie del testo, le quali consentono di chiarirne la natura e al tempo stesso di introdurre un elemento ulteriore di analisi: il modo in cui Tommaso intende la teologia e la ricerca teologica già in questa che è la sua prima grande opera.
Gli studi sulla biografia e sulla produzione letteraria del maestro domenicano collocano la stesura del Commento alle Sentenze in un arco cronologico di circa 5/6 anni, fra il 1251/2 e il 1256, durante i quali non solo il giovane baccelliere tenne lezione sul teso del Lombardo ma ebbe modo di ritornare più volte sui contenuti del proprio insegnamento, rivedendoli e facendo evolvere il proprio punto di vista. Una circostanza del tutto consistente con le prassi scolari di un ambiente, quello dell’università medievale, nel quale la concomitanza dell’insegnamento di molteplici maestri di teologia animava un costante confronto dottrinale. La cornice culturale, ma anche istituzionale e sociologica, all’interno della quale Tommaso si misura con i contenuti del testo del Lombardo, è quella della facoltà parigina di teologia, nella quale le Sentenze godevano di una tradizione di studio e commento che affondava le proprie radici negli ultimi quattro decenni del XII secolo, ossia nel contesto delle scuole teologiche attive a Parigi e nelle quali inizia a prendere corpo la fortuna dell’opera teologica di Pietro Lombardo. Una fortuna che si “ipostatizza” quando, nei primi decenni del XIII secolo, la prassi di legere (ossia insegnare) le Sentenze diviene uno dei pilastri del lavoro teologico, al punto da essere poi assunta come uno degli assi portanti nella formazione teologica interna ad un ordine mendicante, quello del Predicatori, nato con un legame programmatico proprio con il contesto dell’alta formazione universitaria.
Questo ruolo preminente delle Sentenze, che si affiancano alla Scrittura a costituire il “canone” della teologia – ossia il corpus testuale di base su cui poggia tanto l’insegnamento e lo studio quanto la produzione della disciplina teologica –, si inquadra nel processo di progressiva fissazione di canoni testuali paralleli nelle altre facoltà universitarie, a partire da quello aristotelico della facoltà delle arti. Un simile sviluppo culturale, che non ha una semplice valenza pedagogica ma riflette piuttosto una maturazione epistemologica dei diversi ambiti disciplinari, inclusa la teologia, ha certamente risvolti dottrinali ma investe anche il piano istituzionale, politico e religioso, dal momento che, nel quadro della civilizzazione dell’Europa latina del basso Medioevo, lo studium (da intendere sia come cultura che come istituzione scolare) diviene uno dei grandi poteri che modellano e governano la realtà, assieme al sacerdotium e al regnum. Proprio questo status dello studium spiega l’importanza della sua evoluzione storica e il rilievo “sociale” che assumono le grandi discussioni e i grandi scontri dottrinali che nei decenni centrali del XIII secolo si consumano, ad esempio, fra mendicanti e secolari o sulla questione del rapporto fra teologia e filosofia.
Questo quadro generale invita a porre attenzione anche alle prospettive epistemologiche che maturano nel quadro universitario riguardo alla teologia, nella misura in cui queste riflettono le modalità molteplici con le quali questa disciplina guarda la realtà e permettono dunque di valutare le specificità dei diversi autori. Tali raccomandazioni metodologiche si rivelano particolarmente fruttuose nel caso di Tommaso d’Aquino, che gode certamente di una vastissima ricezione e di posterità spesso attenta a considerarlo un interlocutore sempre attuale del dibattito filosofico-teologico, perché giudicato come il portatore della più compiuta sintesi dell’approccio teologico scolastico, e tuttavia poco incline a riconoscerne le specificità rispetto al contesto storico che dell’Aquinate è proprio.
Un’assunzione storico-critica della figura di Tommaso consente allora, nel caso specifico dei due passi del Commento alle Sentenze che qui si prendono in esame, di ricollocare questa opera alla fase iniziale di un itinerario di riflessione sulla natura del sapere teologico che è biografico e intellettuale ad un tempo e che impegna il domenicano dall’inizio della propria produzione teologica, nel 1251/2 sin quasi al 1265 e si traduce, oltre che nel Commento ai quattro libri del Lombardo anche nel Commento al De Trinitate di Boezio, nella stesura della Summa contra Gentiles e della Prima pars della Summa theologiae. È nel prologo del Commento alle Sentenze, un testo che l’Aquinate rivede nei suoi contenuti dopo la stesura iniziale al fine di svilupparne la dottrina, che vengono fissati i tratti essenziali di un’idea di teologia che si confronta direttamente con l’epistemologia aristotelica e si impernia sulla nozione di scientia subalternata, la quale determina anche un peculiare modo di vedere il rapporto di questa disciplina con gli altri saperi.
Per Tommaso la teologia non è in grado di dimostrare i principi da cui muove, ma procede piuttosto dai principi di una scienza superiore che la “scienza di Dio” (scientia Dei), così che la fede diviene la disposizione che consente di conoscere quegli articoli di fede che sono i principi da cui procede la teologia. L’Aquinate non solo applica il criterio della subalternazione delle scienze che trae esplicitamente dall’epistemologia filosofica di Aristotele, ma traccia un parallelo fra il modo di rapportarsi della teologia ai propri principi e quanto accade in altri ambiti disciplinari. Questo perché il sapere teologico, in quanto sapere umano, risponde alle caratteristiche proprie del modo di argomentare e comprendere della natura umana, quasi a dire che anche la teologia è parte dei “saperi” mondani. Questo spiega anche il modo in cui il dottore domenicano concepisce il primato epistemologico della teologia: un primato che è determinato, da un lato, dal fatto di essere ordinata alla contemplazione di Dio che si avrà in modo compiuto nella condizione beatifica (in patria). Dall’altro lato, vi è l’uso che questa disciplina fa delle altre scienze e degli altri saperi in obbedienza al proprio fine e che avviene secondo un altro paradigma aristotelico: quello delle “scienze architettoniche” (scientiae architectonicae). Questo, tuttavia, non significa per Tommaso una teologizzazione del sapere o una finalizzazione alla teologia di tutte le altre discipline, secondo uno schema che fa della prima e delle sue esigenze il criterio regolativo e il limite al valore di verità e utilità di ogni altro sapere. Questa reductio artium ad theologiam, che invece svilupperà Bonaventura da Bagnoregio, non appartiene all’Aquinate, il quale, nello stesso Commento alle Sentenze, parla della contemplazione di Dio (contemplatio Dei) quale fine proprio anche della filosofia, che lo persegue a partire dalla definizione delle realtà create (ex ratione creaturarum). Più ancora, per l’allora baccelliere, la filosofia ha chiaramente una propria autonomia epistemologica rispetto alla teologia e quest’ultima si rende necessaria in ragione di un fine che è quello della felicità perfetta, raggiungibile solo con la contemplazione di Dio dei beati.
Perciò, la filosofia non solo si distingue perché, mentre la teologia arriva a delle conclusioni sulla realtà esistente a partire da principi noti per ispirazione divina – ossia gli articoli di fede –, la filosofia sviluppa argomentazioni e arriva a conclusioni a partire da principi desunti delle realtà create. Più ancora, l’Aquinate sostiene la piena compiutezza del sapere filosofico, poiché mentre la teologia rende l’intelletto perfetto rispetto alla conoscenza infusa e rende perfetta la disposizione d’animo mediante l’amore gratuito: «la filosofia è sufficiente alla perfezione dell’intelletto per quanto riguarda la conoscenza naturale e a quella della disposizione d’animo per quel che concerne la virtù acquisita»1.
L’atteggiamento epistemologico di Tommaso riflette una considerazione della teologia fondata sulla Scrittura (si pensi a Romani 1, 20), ossia che la dimensione creaturale della natura abbia valore in sé stessa e dunque non solo sul terreno simbolico. Questo rende necessario misurarsi intellettualmente con la natura, rispettandone questo tratto essenziale che, del resto, le viene da Dio stesso e riconduce la teologia alla sfera delle discipline scientifiche, che esplicitano le capacità intellettuali della natura umana. Così, la teologia, se muove da principi divinamente ispirati e dunque certi per fede, resta tuttavia un sapere argomentativo, soggetto a “crescita” e che è obbligato a utilizzare quanto può apprendere dalle altre discipline riguardo alla realtà creata, sia essa fisica o sociale.
Tale impostazione, nella quale il lumen della fede rende possibile questa scienza subalternata che è la teologia, traduce sul piano epistemologico l’idea che la grazia suppone la natura, poiché quest’ultima, con particolare riguardo alla natura razionale dell’uomo, è il soggetto che pratica la teologia, ma anche perché il sapere teologico si occupa della “natura” a partire dai principi fissati negli articoli di fede. Tommaso stesso lo spiega, notando come la theologia sia, ad un tempo, sapienza e scienza:
Rispetto a quel che in seguito si domanda, se <la teologia> sia sapienza, si deve dire che questa è sapienza in senso assai proprio, come si è detto in precedenza. E per il fatto che si obietta che <il sapiente> non è massimamente certo, diciamo che è falso: il fedele, infatti, di più e con maggiore fermezza approva questi che sono i principi della fede piuttosto che anche i principi della ragione. E per il fatto che è detto che la fede ricade nella categoria di scienza, non si parla della fede infusa ma della fede che è una convinzione fortificata dalle argomentazioni. La disposizione acquisita di questi principi, cioè degli articoli, è perciò detta fede e non intelligenza, perché questi principi sono al di sopra della ragione e dunque la ragione umana non è capace di cogliere perfettamente quelli stessi principi. E in tal modo si verifica una certa conoscenza imperfetta, non per un difetto di certezza delle cose conosciute, ma per un difetto di colui che conosce. Tuttavia, la ragione condotta per mano dalla fede si sviluppa in questo processo affinché comprenda le stesse cose credibili in modo più pieno, e dunque in un certo modo capisce quelle stesse cose. Per questo si dice in Isaia 7, secondo un’altra versione <del testo sacro>: “Se non crederete, non comprenderete”2.
Il richiamo del quadro epistemologico nel quale si muove Tommaso, per altro già messo in luce nei suoi tratti più peculiari dagli studi di Chenu, Torrell, Oliva e Porro, consente in primo luogo di far emergere la singolarità della prospettiva teologica dell’Aquinate rispetto al panorama teologico del suo tempo e soprattutto a quello parigino. Se infatti il domenicano condivide con altri teologi, si pensi a Bonaventura, l’esigenza tanto di distinguere la teologia dalle altre discipline quanto di fissarne un adeguato spessore epistemologico, dall’altro lato egli matura, già nel Commento alle Sentenze, un’attitudine che è ben altro rispetto al concordismo fra filosofia e teologia o rispetto all’affermazione di un primato della seconda che diviene limite e criterio veritativo della prima. per Tommaso la teologia è parte del sistema dei saperi esperibili dalla ragione umana mediante l’uso di argomenti: questo la rende capace di entrare in relazione con le altre discipline, in ragione di un criterio utilitaristico che tuttavia è reso necessario dal fatto che la comprensione di quel che riguarda la natura in sé stessa considerata è il proprium della filosofia, delle sue parti e delle altre discipline e dunque a quello deve attingere il teologo.
Così, l’Aquinate disegna una mappa epistemologica nella quale la teologia è distinta ma contigua al sapere filosofico e, anzi, di quest’ultimo ha necessità, poiché esso rappresenta il veicolo per accedere alla conoscenza di quelle verità sulla natura che poi la fede permette di meglio comprendere in prospettiva sapienziale perché fa riconoscere in essa elementi che anticipano la contemplatio Dei.
(segue – 2)
1Thomas de Aquino, Super I Sententiarum, prologus,a. 1, ad 2um,ed. Oliva, ll. 54-56: «Philosophia sufficit ad perfectionem intellectus secundum cognitionem naturalem et affectus secundum uirtutem acquisitam».
2Thomas de Aquino, Super I Sententiarum, prologus, a. 3, ad 3um, ed. Oliva, ll. 97-108: «Ad id quod ulterius queritur, an sit sapientia, dicendum quod propriissime sapientia est, sicut dictum est. Et quod obicitur quod non est certissimus, dicimus quod falsum est: magis enim fidelis et firmius assentit hiis que sunt scientiam, non loquitur de fide infusa, set de fide que est opinio fortificata rationibus. Habitus istorum principiorum, scilicet articulorum, ideo dicitur fides et non intellectus, quia ista principia supra rationem sunt et ideo humana ratio ipsa perfecte capere non ualet. Et sic fit quedam defectiua cognitio, non ex defectu certitudinis cognitorum, set ex defectu cognoscentis. Set tamen ratio, manuducata per fidem, excrescit in hoc ut ipsa credibilia plenius comprehendat et tunc ipsa quodam modo intelligit. Vnde dicitur Ysa. vii, secundum aliam litteram ‘Nisi credideritis, non intelligetis’».





























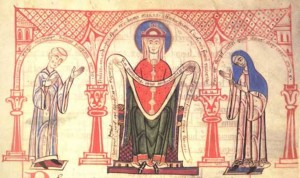
 Area personale
Area personale











