Donne e ordine: S. Tommaso d’Aquino nel magistero (/6), di Riccardo Saccenti
Donne e ordine. Note sull’uso di Tommaso d’Aquino nei documenti del magistero. 6: La consapevolezza di un pensiero che può evolvere
di Riccardo Saccenti
Questo pur sommario percorso attraverso l’analisi storico-critica e filologica dei passi tommasiani del Commento alle Sentenze citati in Inter insigniores, permette di cogliere una evidente distanza fra il contenuto del testo dell’Aquinate e l’uso che se ne fa nella dichiarazione della Congregazione per la dottrina della fede. Se in quest’ultima si ricorre al maestro domenicano per sostenere l’impossibilità fisica per la donna di essere capace di soddisfare la naturale rassomiglianza con il Cristo che è uomo, il Commento alle Sentenze non sembra affatto seguire una declinazione simbolica che si impernia sulle caratteristiche corporee della donna. A sostenere questa posizione sembra essere piuttosto Bonaventura da Bagnoregio, che la utilizza nel proprio Commento precisando però come tale tesi non abbia una certezza necessitante o assoluta ma sia «la più probabile», quella su cui si determina la «comune credenza» (communis opinio) dei dottori.
Tommaso segue invece un’argomentazione che ricalca il suo metodo: assume quanto viene dalla conoscenza della realtà naturale per come è per poi permettere alla ragione di essere guidata dalla fede ad un’intelligenza sapienziale delle cose. In tal modo, l’Aquinate può osservare come la subordinatio della donna, che la rende inadeguata a significare Cristo, che invece richiede il carattere dell’eminentia, abbia un fondamento non corporeo o fisico ma sociale. È in questo aspetto della natura umana, infatti, che si produce una diversità di eccellenza di grado fra uomo e donna, motivata però non su una base ontologica o fisica ma a partire dalla necessità che il genere umano ha di fissare un ordo che, tanto nella casa quanto nel consorzio civile, tuteli il bene facendo sì che i pochi sapienti governino per l’utilità dei loro sudditi. È dunque una motivazione che viene dal sapere filosofico, in particolare da quello etico e politico ispirato dallo studio di Aristotele, che Tommaso deduce l’inadeguatezza della donna a ricevere il sacramento dell’ordine. Sul piano della realtà delle cose Tommaso, ricorrendo all’esegesi talmudica di Genesi 2, 21-23 mediata da Ugo di San Vittore e Pietro Lombardo, sostiene una uguaglianza fra i generi, che infatti sono posti in regime di societas e non di dominio o servitù.
Se questo è il modo con cui Tommaso argomenta e si pronuncia contro l’ordinazione delle donne, è possibile osservare i limiti di una sua riproposizione acritica e destoricizzata nel dibattito teologico attuale. Questo non solo a motivo della profonda distanza storico-culturale fra l’Europa del XIII secolo e il contesto di questi primi decenni del secondo millennio. Sembra sorgere un problema ulteriore, di carattere teoretico e metodologico, connesso alla fedeltà al metodo dell’Aquinate. Perché se per il domenicano la filosofia e la scienza sono saperi necessari al teologo, perché introducono quest’ultimo a quella conoscenza della natura per come è in sé che consente poi alla ragione di essere guidata dalla fede ad approfondire la comprensione sapienziale delle cose create, allora occorre che egli si misuri non con un sistema storicamente definito di saperi ma con le evoluzioni, i mutamenti e gli sviluppi che modificano e approfondiscono il sapere di come la natura è in sé stessa. E questo riguarda tanto la natura fisica quanto quella sociale e psicologica propria dell’uomo.
A ricordare questo criterio di necessario aggiornamento culturale della teologia è lo stesso Tommaso che, sempre nel Commento alle Sentneze, discutendo delle diverse concezioni dei Padri della Chiesa rispetto alla natura dei cieli, spiega che se i più antichi assunsero quale base di partenza la filosofia di Platone, col tempo essi attinsero le proprie conoscenze da quella di Aristotele che, mostrando una più compiuta e solida comprensione della natura dei corpi celesti, permise una più profonda comprensione sapienziale della natura in direzione della contemplatio Dei. Dice Tommaso in quel passo:
Tutti <i filosofi> prima di Aristotele ritennero che il cielo fosse per natura composto dai quattro elementi. Aristotele per primo rigettò questa via e ritenne il cielo essere una quinta essenza, priva di peso e leggerezza e contraria agli altri elementi, come si evince dal primo libro del De caelo et mundo. E a motivo della forza delle sue argomentazioni, i filosofi successivi convennero con lui, così che oggi tutti seguono la sua opinione. In modo simile, anche gli esegeti della Scrittura si divisero su questo punto, per il fatto che seguirono filosofi diversi, dai quali vennero istruiti nelle questioni filosofiche. Infatti, Basilio e Agostino e molti fra i santi, nelle questioni filosofiche che non riguardano la fede, seguirono le opinioni di Platone, e perciò ritennero che il cielo fosse della natura dei quattro elementi. Dionigi, invece, segue quasi sempre Aristotele, come è chiaro a colui che con attenzione esamina i suoi libri: perciò lui stesso separa i cori celesti dagli altri corpi. E dunque, seguendo questa posizione, dico che il cielo non è della natura dei quattro elementi ma è un quinto corpo1.
Volendo dunque affrontare la questione dell’ordinazione della donna attraverso una ricerca teologica condotta ad mentem Thomae, il teologo dovrebbe forse misurarsi più che con la dottrina morale e antropologica dello Stagirita, con gli sviluppi molteplici del pensiero filosofico e delle scienze umane e sociali, anche cristianamente ispirato, con riguardo alla dignità dell’essere umano e della donna in particolare. È lì che occorrerebbe permettere alla fede di condurre per mano la ragione ad una maggiore e più chiara intelligenza sapienziale delle cose che si credono riguardo a Dio e alla sua chiesa.
(fine -6)
1Thomas de Aquino, Super II Sententiarum d. 14, q. 1, a. 2, sol., ed. Mandonnet, p. 350: «Circa hanc quaestionem fuit philosophorum diversa positio. Omnes enim ante Aristotelem posuerunt, caelum esse de natura quatuor elementorum. Aristoteles autem primus hanc viam improbavit, et posuit caelum esse quintam essentiam sine gravitate et levitate, et aliis contrariis, ut patet in I Caeli et mundi …; et propter efficaciam rationum eius, posteriores philosophi consenserunt sibi; unde nunc omnes opinionem eius sequuntur. Similiter etiam expositores sacrae Scripturae in hoc diversificati sunt, secundum quod diversorum philosophorum sectatores fuerunt, a quibus in philosophicis eruditi sunt. Basilius enim et Augustinus et plures sanctorum sequuntur in philosophicis quae ad fidem non spectatn opiniones Platonis: et ideo ponunt caelum de natura quatuor elementorum. Dionysius autem fere ubique sequitur Aristotelem, ut patet diligenter inspicienti libros eius: unde ipse separat corpora caelestia ab aliis corporibus. Et ideo, hanc positionem sequens, dico quod caelum non est de natura quatuor elementorum, sed est quintum corpus».





























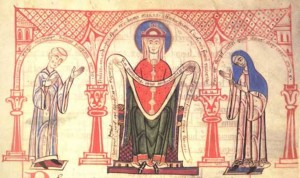
 Area personale
Area personale











