Dinamiche storiche e tensioni teologiche: possibilità e limiti di “Antiquum Ministerium” (di Riccardo Saccenti)
Con sguardo sereno, e con piglio sicuro, Riccardo Saccenti esamina il nuovo testo sul “ministero del catechista” alla luce degli sviluppi storici e delle tensioni tra impostazione teologica, evidenze ecclesiologiche e tradizione giuridica: un quadro in movimento, che presenta aperture e chiusure. Lo ringrazio per avermi concesso di pubblicare questa sua importante riflessione. (ag)
1. La firma di Antiquum Ministerium segna, come è stato opportunamente osservato, un passaggio rilevante nella ricezione del Concilio Vaticano II. A 56 anni dalla chiusura il motu proprio segna l’istituzione di un ministero nuovo, quello del catechista, che amplia i confini della ministerialità all’interno della chiesa collocandolo espressamente dentro l’orizzonte di una pluralità di munera espressa «nel servizio di uomini e donne i quali, obbedienti all’azione dello Spirito Santo, hanno dedicato la loro vita per l’edificazione della Chiesa» (nr. 2). Se il testo riconosce l’esercizio della catechesi come un ministero radicato nella storia lunga e plurale della chiesa, lo lega però espressamente alla condizione laicale. Si è correttamente osservato come questa specifica modalità di presentare il ministero del catechista non sia neutra: parlare di «ministero laicale di catechista» lega questo ministero ad una specifica condizione del cristiano, connotata sul terreno giuridico della codificazione canonica. Una scelta, quella di legare il ministero del catechista alla condizione laicale, nel quale emerge una sorta di contraddizione teologica interna al magistero che si palesa anche all’interno del testo stesso di Antiquum Ministerium.
2. Gli espliciti riferimenti ai documenti del Concilio e al Codice di Diritto Canonico chiariscono come il motu proprio parli di laici con riferimento a quei cristiani che non hanno ricevuto il sacramento dell’ordine e sono qualificati da un esercizio dell’apostolato che «possiede una indiscussa valenza secolare» (n. 6). La catechesi viene, per così dire, “riservata” a quanti si trovano nella specifica condizione canonica di “laico” e definita, sulla scorta di Lumen Gentium 33, nei termini di una collaborazione dei laici all’apostolato della gerarchia. In questo senso Antiquum Ministerium sembra porsi in continuità con il linguaggio del Concilio e veicolare una traduzione dell’idea di chiesa nella quale la nozione di popolo di Dio resta segnata un’articolazione giuridica fra laicato e clero che però viene giocata come se avesse il peso e la portata di una articolazione teologica.
Eppure, è proprio il testo del motu propriu a fare un passo ulteriore rispetto alla stessa ecclesiologia conciliare per quello che riguarda la natura dei ministeri, il loro fondamento teologico e la loro funzione nella vita del corpo ecclesiale. Lo fa nei primi due numeri del documento, che si presentano come un’articolata pericope del capitolo 12 della prima epistola di Paolo ai Corinti, là dove l’Apostolo si sofferma a indagare la teologia dei carismi presenti nella chiesa e ne chiarisce il fondamento. «Alcuni perciò – spiga Paolo – Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri; poi ci sono i miracoli, quindi il dono delle guarigioni, di assistere, di governare, di parlare varie lingue. Sono forse tutti apostoli? Tutti profeti? Tutti maestri? Tutti fanno miracoli? Tutti possiedono il dono delle guarigioni? Tutti parlano lingue? Tutti le interpretano? Desiderate invece intensamente i carismi più grandi. E allora, vi mostro la via più sublime» (1 Cor 12,28-31).
Il passo paolino è ben più di un elenco di funzioni svolte all’interno della chiesa: al contrario esso riconduce l’esercizio di determinati compiti all’interno della comunità al possesso di carismi che sono dono dello Spirito. È lo Spirito, infatti, ad agire attraverso l’opera dei cristiani, in una manifestazione che è finalizzata all’utilità comune (1Cor 12, 7) e che dunque non opera una gerarchizzazione né fra i carismi né fra le opere che quei carismi determinano. Se è lo Spirito ad operare, nell’economia dell’agire dello Spirito stesso non vi è una differenziazione di ordine giuridico-gerarchico ma piuttosto il riconoscimento della specificità di ogni carisma in ragione della specifica esigenza a cui risponde.
Il punto è spiegato nello stesso capitolo 12, in un ulteriore passo citato da Antiquum Ministerium: Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti.A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune: a uno infatti, per mezzo dello Spirito, viene dato il linguaggio di sapienza; a un altro invece, dallo stesso Spirito, il linguaggio di conoscenza; a uno, nello stesso Spirito, la fede; a un altro, nell’unico Spirito, il dono delle guarigioni; a uno il potere dei miracoli; a un altro il dono della profezia; a un altro il dono di discernere gli spiriti; a un altro la varietà delle lingue; a un altro l’interpretazione delle lingue.Ma tutte queste cose le opera l’unico e medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole» (1 Cor 12,4-11).
Lo Spirito è allora la fonte unificante di una pluralità di carismi e ministeri, i quali sono dispensati nella comunità cristiana in ragione del battesimo che fonda la capacità di ciascuno di accogliere il dono di uno o più carismi e al tempo stesso fa della messa in opera di quel carisma una manifestazione dell’agire dello Spirito il cui valore risiede nel fondamento pneumatologico e nel munus battesimale e non dalla collocazione gerarchica che gli viene attribuita in una specifica fase della storia della chiesa.
3. Quella enucleata attraverso il passo paolino è una teologia dei ministeri che non suppone una distinzione interna in ragione dell’ordo giuridico secondo cui è strutturato il popolo di Dio. Ed è questo un aspetto giustificato dal fatto che la dimensione sociologica e giuridica nella quale la fede cristiana si traduce non è stabile, ma storicamente mutevole, anche e soprattutto per quello che riguarda le forme che la ministerialità viene assumendo nel corso dei due millenni di storia cristiana. Fa fede, al riguardo, la molteplicità di forme che il presbiterato assume nel corso dei secoli o il modo in cui i sacramenti stessi trovano una loro piena intelligenza teologica – con la conseguente traduzione liturgica e giuridica – solo dopo un lungo e complesso processo fra XII e XIII secolo che sarà codificato in via definitiva solo con il concilio di Trento.
Sul terreno strettamente teologico, la seconda parte di Antiquum Ministerium, esplicitamente ancorata all’idea della catechesi come ministero prettamente “laicale”, confligge con questi primi due numeri del documento, dove tutti i ministeri, indistintamente, sono ricondotti ad: «una diffusa forma di ministerialità che si è resa concreta nel servizio di uomini e donne i quali, obbedienti all’azione dello Spirito Santo, hanno dedicato la loro vita per l’edificazione della Chiesa» (n. 2). Tuttavia, se visto con uno sguardo storico-critico, il documento pontificio riflette uno stato di cose non nuovo nella chiesa e consente una più chiara presa di coscienza delle caratteristiche qualitative del processo storico nel quale l’intelligenza della fede e la coscienza ecclesiale sono calate in questo momento. Il motu proprio, infatti, riflette certamente una continuità col lessico verbale e mentale del Concilio, il quale proprio sulla nozione di “laico” resta ancora legato ad una impostazione tridentina. In questo senso esso sembra essere un prolungamento del Vaticano II di dare una definizione “in positivo” della condizione canonica del laico, il quale non è più il cristiano privo del ministero ordinato, ma qualcuno a cui può essere attribuito uno specifico ministero, quello di catechista. Tuttavia, mantenendo una logica di distribuzione dei sacramenti in ragione dello status giuridico di chi li riceve, si rimane dentro uno schema binario fra laici e chierici che da ai secondi un primato qualitativo che diviene autoritativo. Al tempo stesso, però, la pericope paolina con cui prende il via il motu proprio, capovolge questo impianto perché non si pone il problema di quali ministeri distribuire nella chiesa e a chi, ma muove dal riconoscimento che il carisma, che fonda i ministeri, è dono dello Spirito e che la chiesa come comunità è chiamata a riconoscere la presenza di tali carismi al suo interno e ad incoraggiare una vocazione alla ministerialità che è fondata sul battesimo, dunque propria di ciascun cristiano. Risuona qui l’esortazione con cui Paolo chiude il capitolo 12: «Aspirate ai doni più elevati» (1Cor 12, 31).
4. Il combinato di una intelligenza della ministerialità radicata in una rilettura neotestamentaria dei carismi, con la loro radice battesimale, e di una sua traduzione normativa dentro una ecclesiologia duale di chierici e laici esplicita uno stato di cose nel quale l’emergere di elementi che arricchiscono la comprensione della fede non trova ancora corrispondenza con la capacità di esprimere questa novità nei linguaggi parlati e mentali della chiesa. Una circostanza ricorrente nella storia della chiesa, che obbliga a tempi lunghi e dunque alla pazienza. Il Vaticano II, del resto, nella sua riflessione ecclesiologica sul Popolo di Dio “intuisce” una ministerialità battesimale, dunque non fondata sulla sacralizzazione di una determinazione giuridica. Tuttavia, esso, anche per ragioni che attengono allo specifico contesto della cultura teologica degli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso, non ha ancora le categorie adeguate ad esplicitarla pienamente e a procedere ad un ripensamento del livello giuridico capace di rispondere alla nuova intelligenza teologica. La costruzione e l’elaborazione di una forma mentis e di un lessico adeguato a dare voce alla coscienza teologica di una chiesa che si sa Popolo di Dio e che si sa radicata nel battesimo, resta, ancora oggi, un qualcosa di non compiuto che interpella non solo i teologi ma tutti i battezzati, perché investe il mandato della chiesa intera e l’agire del medesimo Spirito che «opera tutto in tutti» (1Cor 12, 6) e fonda la diversità dei carismi e dei ministeri. In questo senso, proprio i primi due numeri di Antiquum Ministerium rappresentano l’elemento teologicamente più rilevante in questo itinerario di maturazione ecclesiale. Essi esplicitano, col linguaggio neotestamentario, i fondamenti di una ministerialità che non è de iure ma sorge dalla “aspirazione” a cui tutti i battezzati sono chiamati (vocati) e dunque dal riconoscimento che i doni dello Spirito sono dispensati nel popolo di Dio. Fatto, questo, che fa della ministerialità non una concessione ma l’atto ecclesiale di riconoscimento della presenza dei carismi donati dallo Spirito.
Riccardo Saccenti





























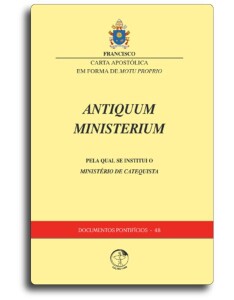
 Area personale
Area personale












Spunti interessanti nell’intervento di Saccenti. Riconoscere i doni, non finire per ingabbiare ulteriormente.
https://gpcentofanti.altervista.org/la-cultura-ingabbiata-e-il-popolo-profeta/