Officium: la archeologia storica di Cortoni e la archeologia filosofica di Agamben
Più di una volta mi è capitato di trovare cose molto belle, utili e acute in libri di cui non condividevo assolutamente la tesi centrale. Perché gli autori, mentre cercano di dimostrare il loro punto centrale – che talvolta lascia del tutto indifferenti o contrariati – allegano prove, citano testi, collegano situazioni o rivelano retroscena che meritano il massimo rispetto. Si può rispettare profondamente un testo anche quando se ne deve respingere nel modo più netto la tesi centrale. Così è capitato anche questa volta: grazie alla grande sintonia con un libro storico, e al profondo dissenso verso un libro teorico, ho intravisto grazie a loro, qualcosa di nuovo.
In effetti, a ben vedere, l’interesse che da qualche tempo mi spinge a fare ricerche intorno al concetto di “officium” negli studi di teologia liturgico-sacramentale, fino a farne quasi un altro “genere” del sacramento, accanto al “segno”, alla “causa” e al “rito”, è scaturito dal formidabile incrocio tra due libri. Un libro prevalentemente storico, ma non privo di spunti sistematici acuti, come C.U. Cortoni, Christus Christi est sacramentum. Una storia dei sacramenti nel Medioevo, (Ecclesia Orans. Studi e ricerce, 4), Napoli, Editrice Domenicana, 2021. L’altro libro, solo teorico, ma con una dovizia di citazioni medievali, è G. Agamben, Opus Dei. Archeologia dell’ufficio, Homo sacer, II, 5, Torino, Bollati Boringhieri, 2011.
In che senso il concetto di “ufficio” risulta decisivo in entrambi i testi? Perché la ricostruzione della “storia della liturgia” esige, precisamente, una riconciliazione con questo termine. In quale direzione muove questa affermazione? Provo a spiegarlo in poche parole.
a) le diverse competenze in ambito liturgico
Una risistemazione delle competenze in campo liturgico appare da tempo necessaria. Soprattutto una riequilibratura e una precisazione delle pretese di ciascuna delle forme di intelligenza che storicamente si sono manifestate intorno a questo “oggetto”. Anzi, sono le forme di intelligenza ad aver modellato l’oggetto. Dirò pertanto che il definirsi del “genere”, come “predicato, immanente alla essenza, di parecchi oggetti differenti per specie” (Aristotele), ha di fatto influito pesantemente sulla esperienza che dell’oggetto faceva la Chiesa e il singolo cristiano. Dire che la liturgia è “un dovere”, oppure che è “un segno-causa”, o che è un “rito” costituisce un “ordine del discorso” che modifica l’esperienza.
Molto ci siamo impegnati, negli ultimi 200 anni, per cercare di comprendere che cosa è accaduto della liturgia a partire dall’inizio del XIX secolo. Se è stato possibile identificare addirittura la “nascita della liturgia” in questo contesto storico, è chiaro che qualcosa di veramente importante è avvenuto e poi è stato recepito dapprima da alcune espressioni della prassi e della ricerca ecclesiale, ma poi, mediante il Concilio Vaticano II, nel corpo intero della Chiesa, in forma ufficiale. In un certo senso la liturgia è stata ricompresa da parte della teologia e “come” teologia.
Ma che cosa significa davvero questa frase? In che senso è possibile sostenere che la liturgia ha dovuto essere “ricompresa” da parte della teologia e “in quanto” teologia? Non è vero che anche il passato avesse buone comprensioni e ottime sintesi teologiche a proposito della celebrazione rituale? E’ evidente che entrambe le affermazioni antitetiche hanno il loro fondamento. E’ vero infatti che la lunga tradizione della Chiesa ha saputo elaborare forme anche molto raffinate di rilettura teologica della dimensione cultuale e rituale della fede. Ma ciò non toglie che anche nella consapevolezza di uomini come Antonio Rosmini, Prosper Guéranger, Maurice Festugière, Romano Guardini, Odo Casel – per citare solo i nomi che coprono lo spazio dai primi decenni del XIX secolo alla metà del XX secolo – sia stata chiara la coscienza di una grande “rivoluzione” nel rapporto tra la teologia e il rito.
Mi pare, tuttavia, che resti ancora piuttosto oscuro in che senso questa legittima domanda di “nuova comprensione” fosse giustificata rispetto a ciò che la tradizione aveva elaborato fino a quel momento. Come possiamo capire in che modo è emersa, contemporaneamente al mutare culturale e sociale del mondo agli inizi del XIX secolo, una richiesta di chiarificazione della dimensione simbolico-rituale della fede, che la tradizione fino a quel momento aveva conosciuto, considerato, trattato, ma non sviluppato in modo diretto ed esplicito come problema teologico. Qui nasce quella che a giusto titolo Romano Guardini ha chiamato liturgische Frage, “questione liturgica”. La domanda intorno alla liturgia cambia e perciò il fenomeno merita di essere osservato in modo nuovo e con categorie diverse.
b) la duplice provocazione di Cortoni e Agamben
Per elaborare tale questione lo storico e il filosofo mettono in campo tutta la loro passione. Il primo esamina con una cura rara e con straordinarie “tavole sinottiche” gli usi che i testi liturgici, dall’alto medioevo fino alla scolastica, l’impiego dei termini fondamentali per designare ciò che noi moderni chiamiamo liturgia e sacramenti. E trova il termine “officium” come risorsa formidabile di una mens che non accetta con troppa ingenuità la “grande divisione”, che si imporrà dopo Pietro Lombardo, e che scinderà gradualmente, sempre di più, la azione di culto dell’uomo verso Dio dalla azione di grazia di Dio verso l’uomo. Ciò che “officium” permette di “tenere insieme”, nel sistema prescolastico di sistematizzazione del sapere ecclesiale, è proprio questa unione di culto e santificazione, che invece il duplice concetto di “segno” e di “causa” vedrà compromesso.
Da parte sua Agamben, con una forte vena polemica nei confronti della riscoperta della liturgia nel XX secolo, che non avrebbe compreso nella sua chiarezza la “archeologia dell’ufficio”, propone una lettura meramente “effettuale” della liturgia, di cui “opus dei” e “officium” rappresenterebbero la migliore definizione. Il mistero liturgico risulterebbe incompreso dalla moderna teologia, e Agamben vorrebbe restituirlo “al rigore e allo splendore dei grandi trattati medievali di Amalario e Guglielmo Durando” (8).
In che cosa consisterebbe questa “chiarezza” del termine “officium”? Si tratterebbe di una “riduzione politica” del termine, che Agamben vorrebbe dimostrare come sua verità. Officium sarebbe la formulazione originaria, e originale, di una differenza tra dover essere ed essere, che starebbe alla radice tanto di Kant, quanto di Kelsen. Un “paradigma del comando” sarebbe evidente nell’uso secolare della parola officium da parte della teologia medievale.
c) il punto cieco: Kant come erede di Amalario?
Che cosa sfugge di decisivo, ad Agamben? Egli sta sovrapponendo, con salti storici e filologici del tutto arbitrari, una teoria “cultuale” dell’officium, con una teoria “santificante” dell’opus operatum. Questa confusione, che identifica le fonti che “distinguono” tra santificazione e culto, e quelle che non distinguono, mi sembra impedirgli di apprezzare non solo la “radicazione teologica” della terminologia, ma anche la differenza tra affermazioni scolastiche e prescolastiche. Egli confonde così il riferimento all’officium con il riferimento al sacramento. L’uso non è univoco tra epoche diverse, ma è del tutto evidente se ogni fonte viene contestualizzata. Il culmine di questa confusione si trova nella analisi a cui egli sottopone il pensiero di O. Casel, che appare sfigurato nelle sue intenzioni. Lo stesso termine-chiave della teologia di Casel – Kultmysterium – è evidentemente la unione provocatorio di ciò che la scolastica ha diviso: di culto e di mistero. “Mistero del culto” rappresenta non il tentativo politico di fondare una effettualità della operatività, ma quello di unire azione dell’uomo e azione di Dio nel culto. Di questa intenzione profonda e chiara di Casel, Agamben non dice nulla. Perché nulla può dire che trascenda e trasgredisca la riduzione dell’ontologia dell’ufficio alla ontologia del comando. E questa tesi brillante, imposta come verità archeologica a priori, che si impone su tutti i testi e che trascura tutte le necessarie distinzioni, rischia continuamente di contraddire la realtà e anche la logica. Ma anche questo non è per caso.
d) il guadagno dal confronto
Cionondimeno, il confronto che indirettamente si è creato tra Cortoni e Agamben è stato un grande guadagno. Molti “dati”, che Agamben ha collegato con grande finezza, risultano non solo utili, ma illuminanti, purché liberati dalla ideologia che li imprigiona. Voler utilizzare Ambrogio come un “allievo di Cicerone” e spostare tutto l’interesse spirituale ed ecclesiale sul piano di una tesi strettamente bio-politica è una impresa paradossale e assai azzardata. Che, mostrando il suo limite, indica però anche un percorso fecondo. Quello di lavorare con cura, con maggiore cura, con lo stesso concetto di “officium”, riconoscendolo davvero come un “genere della liturgia”, diverso da “segno-causa” e differente anche dalla versione più nuova e più antica del XX secolo, ossia del “genere del rito”.
Alla fine è giusto tornare al libro di Cortoni, che si muove sui testi con la cautela di chi sa che gli storici non devono mai sottopporre le parole a forzature eccessive. Nessuna pretesa di trovare nell’officium medievale dei monaci, dei vescovi e dei teologi il paradigma della effettualità e del comando del processo ad Eichmann. Piuttosto, la accurata analisi di un passaggio delicato intorno al significato di officium, che può diventare “effettuale” solo quando dall’officium si distingue il remedium, dal culto si separa la santificazione. Questa differenza, che si fonda sul sapere scolastico, non esiste né in Amalario, né in Guglielmo Durando. Manca loro la categoria per poter parlare, pensare e credere così. Per questo “officium” non indica mai un “paradigma del comando”, perché non è questa la parola che si è utilizzata per dire la effettualità. Piuttosto indica, secondo la archeologia filologica di Cortoni, la traccia di una “percezione unitaria” della azione di Dio e dell’uomo. Leggendo Cortoni si comprende, in una forma davvero singolare, quanto la tradizione si sia stratificata secondo tra diversi “ordini del discorso”. Il genere dell’officium, quello del segno-causa e quello del rito si sono susseguiti nella storia, sovrapponendosi, contestandosi, ignorandosi, dimenticandosi l’un l’altro. Una ripresa attuale di questa tradizione composita può far bene alla intelligenza della liturgia. Ma solo a condizione che le distinzioni non vengano perdute e che non si attribuisca alla parola “officium” un significato totalmente estraneo al riferimento cultuale, rituale e sacramentale che presuppone, inaggirabilmente, almeno nei testi teologici, una alterità rivelante, agente e amante, cui l’officiante risponde da orante, co-agente e co-amante. Senza questa alterità, l’ufficio sarebbe sempre chiuso o produrrebbe mostri tremendi, intra et extra moenia ecclesiae.





























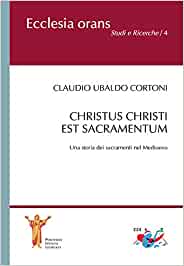

 Area personale
Area personale












Tornare sempre a Gesù con l’aiuto di tutti è un dono di Gesù stesso in un libero cammino di accoglienza…
https://gpcentofanti.altervista.org/miei-testimoni-perche-con-me-fin-dal-principio/