Un nuova storia dei sacramenti nel Medioevo: il manuale di Claudio Ubaldo Cortoni
Proprio oggi ho ricevuto la copia del libro che qui voglio presentare. Vi è, in questo, una coincidenza singolarissima. Proprio oggi si è celebrata l’ultima preghiera che ha accompagnato il P. Ghislain Lafont alla sepoltura. Nel libro che presento si comincia proprio da una formidabile distinzione che Lafont ha insegnato all’autore, il quale ne assume la eredità e la impiega per leggere la storia dei sacramenti nel Medioevo. Le categorie elaborate da Lafont diventano efficaci nell’opera di Cortoni. Il rapporto tra maestro e allievo funziona così in pienezza. E da grandi opere nascono grandi opere. Pubblico qui la Presentazione che l’autore mi ha chiesto in apertura del libro.
La storia medievale dei sacramenti e il suo impensato
Accade non di rado che lo storico dei sacramenti sia poco nutrito di buona teologia, e che il teologo dei sacramenti, a sua volta, sia storico solo di occasione, per non dire di seconda mano. Succede che il primo si lasci imporre le categorie sistematiche senza piena avvertenza, e che il secondo “usi dei fatti” senza troppa discrezione. Questa condizione della ricerca genera frequentemente grandi illusioni e cade più spesso in gravi ingenuità. Lo storico, dunque, usa con disinvoltura schemi sistematici più grandi di lui, che “impone acriticamente” ai dati di studio. Mentre il teologo assume le “storie” in modo altrettanto ingenuo, levando la parola alla bella e imbarazzante libertà dei “fatti documentati”. Quando accade invece, come in questo caso, che lo storico abbia elaborato una domanda sistematica forte e articolata, e che il teologo sia dotato di cultura filologica e storica “da ricercatore”, e che, per di più, le due figure coesistano, più o meno armonicamente, nella stessa persona, allora il risultato non può che essere di grande rilievo e il testo si rivela capace di portare a conoscenze assai consistenti sul piano scientifico e pedagogico. Desidero presentare, in modo sintetico, i vantaggi che derivano da questa benedetta “congiunzione” di metodi e di linguaggi, così come la troviamo esposta dall’autore di questo manuale.
La storia medievale e le domande moderne e contemporanee
Fin dalle prime righe della sua Introduzione Claudio U. Cortoni mostra le “carte” con cui vuole giocare: ossia propone in sintesi le “quattro soglie di modernità” (una in più rispetto alle tre indicate da Gh. Lafont) che permettono – a lui e a noi – di comprendere che cosa cercare nella storia medievale dei sacramenti. Si tratta, quindi, di uno sguardo “dalla fine della storia”, ossia dalla inaugurazione di una comprensione “moderna” (e contemporanea), di cui si indagano nel medioevo (alto e basso) le condizioni di possibilità, le opposizioni polari e le contraddizioni. In altri termini, cerchiamo nel medioevo sacramentale le “forme” – mentali e pratiche – per comprendere ciò che dal XV è diventato sempre più ovvio e perciò anche incompreso. La storia medievale dei sacramenti diventa, così, una forma di radicale interrogazione delle categorie moderne e contemporanee del sapere sacramentale e liturgico, delle loro luci e delle loro ombre. Le 4 soglie, su cui sostare nello studio, sono presentate dall’autore con le seguenti parole:
“il passaggio da un pensiero allegorico ad uno filosofico o dalla libellistica alla dialettica; i modelli ecclesiologici che si sono succeduti; la forte tensione escatologica che animava l’uomo medievale, tanto da modellare su questa il proprio ordine sociale; le nuove eterodossie legate da una parte alle controversie sull’incarnazione della seconda Persona della Trinità e dall’altra al tentativo di riformare la chiesa sulle istanze evangeliche”
Come è evidente, questi quattro punti emergono da domande contemporanee, la cui elaborazione è tipica del XIX e XX secolo. Rispondono, in un certo senso, ad una ricerca che, dalla metà del XIX secolo, ha fatto sorgere “movimenti” di riscoperta del patrimonio biblico, patristico, liturgico ed ecumenico, che poi nel XX secolo ha lavorato, più o meno concordemente, ad una “riforma della Chiesa”. La quale, appunto, ha dovuto elaborare “forme di linguaggio”, “modelli di Chiesa”, “recuperi della escatologia” e “ripensamenti di dottrina e disciplina” tra loro strettamente correlati.
Scavando nei secoli VII-XIV, C. Cortoni porta alla luce, su questo “tema sacramentale”, una elaborazione preziosa e strutturale, carsica o evidente, ben nota o coperta di polvere, che può apparire del tutto chiara solo alla luce di queste “domande sistematiche”, che corrono lungo tutte le pagine del volume. La cui struttura è, appunto, di carattere non semplicemente “cronologico”, ma “sistematico”.
L’indice del volume
Il volume, dal titolo Christus Christi est sacramentum, si sviluppa secondo un ordine molto avvincente. E’ strutturato in 4 parti che sono, allo stesso tempo, sviluppo storico del sistema teologico e articolazione sistematica della storia ecclesiale. Ecco i 4 passaggi:
I) Una chiesa «quasi persona». Ecclesiologia e sacramentaria medievali
II) i sacramenti nella manualistica medievale
III) Il sacramento in genere
IV) Il settenario sacramentale
In ognuna di queste parti si sviluppa un lavoro di accurata documentazione, che attesta la pluralità di prospettive e la differenza di sguardi, non solo cronologicamente distinta, ma anche articolata secondo le scuole, le influenze e i problemi da affrontare. Assai interessante è poi, nell’ultima parte, la puntuale presentazione di tutto il settenario sacramentale, con l’utilizzo di categorie e di prospettive davvero originali.
Mi limito ad indicare, in modo puramente rapsodico, alcuni degli spunti più significativi di ogni singola parte, in relazione alla domanda sistematica che li alimenta.
La riscoperta dell’orizzonte ecclesiologico dei sacramenti
Il punto di partenza del libro è il passaggio da una lettura “tripartita” (laici, monaci, chierici) del corpo ecclesiale, all’affermarsi del modello dei “due ordini” (chierici/laici). Si tratta dell’orizzonte istituzionale entro cui la riflessione sacramentale si sviluppa, tematizzandolo solo parzialmente. Così, potremmo dire, vi è una “presupposizione ecclesiale” al sapere liturgico e sacramentale che merita uno sguardo iniziale. In questo spazio, la comprensione della Chiesa come corpo mistico si traduce, lungo i secoli, nella lettura del corpo sacramentale nel corpo ecclesiale. Il sorgere di una nuova mediazione giuridica, che rilegge la tradizione liturgica e sacramentale, permette una ricostruzione del sapere e del fare ecclesiale di cui la modernità sarà erede solo in parte inconsapevole.
La costruzione del manuale sui sacramenti
Il secondo passaggio che viene studiato con cura è il sorgere del modo “sistematico” di intendere i sacramenti. I fattori da considerare sono molteplici: da un lato la introduzione del “sapere dialettico”, che sostituisce gradualmente, anche se mai completamente, il sapere epistolare, omiletico o allegorico; d’altro canto evolve anche il “sapere liturgico”, che, pur mantenendo una sua autonomia, finirà in larga parte per essere tradotto nelle categorie scolastiche. Alcuni schemi sinottici, che mostrano la evoluzione degli “indici” delle opere più rilevanti tra il IX e il XIII secolo, permettono la considerazione degli spostamenti di accento, delle perdite e dei guadagni, che poi l’età moderna e contemporanea hanno ricevuto e a loro volta elaborato, superato o tradito.
Il sacramento come “genere” del sapere teologico
Il terzo momento del testo è la lenta elaborazione, studiata cronologicamente, del “genere sacramentale”, che avviene in stretta relazione con la comprensione del sacramento eucaristico. Una messa a punto della nozione, che si formalizzerà soltanto agli inizi del XIII secolo, attraversa la prima e la seconda controversia eucaristica, per giungere, infine, ad una rielaborazione mediante le categorie dialettiche della scolastica e della nuova scienza canonistica. Anche in questo caso, la conoscenza dettagliata degli intrecci tra eredità agostiniana, suo riutilizzo nelle controversie intorno a Pascasio e a Berengario, ed esito scolastico, predispongono un materiale che la recezione moderna e contemporanea sarà in grado di discernere con lucidità ora più ora meno adeguata.
Lo sviluppo sistematico di ognuno dei sette sacramenti
La individuazione dei “sette sacramenti” – legata da un lato al formularsi della categoria “generica” di sacramento e dall’altro alla contrapposizione alle nuove eresie – viene presentata in due momenti:
– il primo è lo strutturarsi del settenario e la sua “logica interna”. Vengono presentate, in successione, le principali comprensioni sistematiche (Ugo di S. Vittore, Abelardo e Pietro Lombardo) per confrontarle, poi, con la versione di Guglielmo Durante. Ne emerge una “logica complessa”, sia nella successione dei 7, sia nella identificazione della logica di “necessità”, di “dignità” e di “volontà” che essi comportano.
– il secondo è lo sviluppo della comprensione di ognuno dei sette, che viene proposta con dovizia di riferimenti e sempre con una attenzione vigile allo sviluppo della sistematica dal IX secolo al XIV. Di ognuno dei sacramenti si studiano le teorie prevalenti. Molto limpida appare, in questi passaggi, l’analisi del trasformarsi del sapere eucaristico. E’ un quadro assai suggestivo di teorie, di influenze, di sintesi e di conflitti, che illustra la grande libertà del dibattito e i veri temi del confronto. Si scopre, così, che le controversie eucaristiche rispondono a domande che non riguardano anzitutto l’eucaristia, ma la cristologia, la soteriologia e l’ecclesiologia.
Ognuno dei setti sacramenti viene riletto in una molteplicità di prospettive, che dipendono dalle scuole teologiche e dalle questioni (classiche o nuove) che dovevano essere affrontate. Così, nella sequenza stabilita da Pietro Lombardo, ma integrata dalle categorie di Guglielmo Durante, una serie innumerevole di letture viene ad arricchire la testimonianza della elaborazione nei 7 secoli dell’evo di mezzo. Vorrei dire che, in ogni singolo trattato su ciascuno dei 7 sacramenti, il paragrafo di questo volume dedicato al sacramento corrispondente diventa punto di riferimento obbligato, sia in termini informativi, sia in termini di discussione critica. Per non dimenticare i gustosissimi schemi “in sinossi”, dove si possono scoprire dal confronto cose tanto disparate e tanto strane, e che invece risultano profondamente convincenti e illuminanti.
Tutto questo porta ad una grande rinfrescata gettata sulle forme moderne e contemporanee di riflettessione sul sacramento. Poiché il Medioevo attesta, sia pure nell’affermarsi di una tendenza che sarà poi assunta come prevalente, una tale libertà di riflessione e una così grande parrhesia di confronto, che leggerla oggi può fare solo bene al dibattito ecclesiale e alla formazione degli studenti e dei ministri. E così, da un libro che è veramente un “manuale”, ma che dà il gusto della ricerca perché frutto di letture dirette e di prima mano, si può imparare molto non solo del Medioevo, ma della Chiesa moderna e anche del nostro tempo odierno. Anzi, questa lettura del medioevo ci offre la chiave per cogliere, con sorprendente ricchezza, l’”impensato della tradizione” e quindi una condizione di possibilità della sua continuazione oggi, anche sotto altra specie. Alla scuola di teologia mancava uno strumento come questo. Ora difficilmente se ne potrà fare a meno, sia per uno studio accademico davvero fondato e critico, sia per una formazione di base opportunamente aperta e sensibile.





























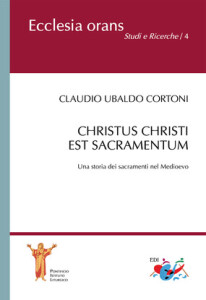
 Area personale
Area personale












Molto stimolante questa Presentazione. Anche perché non riduce a “sacramentaria” la ricerca inesausta dei sacramenti, ma la inserisce nella vita della Chiesa nella storia. Solo lì, nella vissuta crescita comune, le competenze rischiano meno di ridursi ad elucubrazioni intellettualistiche.
https://gpcentofanti.altervista.org/la-sinodalita-nei-vangeli/
Un’analisi sia storica che teologica dei sacramenti è sicuramente molto importante. Questa presentata, elaborata da uno studioso di entrambe le discipline, deve esserlo particolarmente e può orientare anche l’oggi.
Cercherò di leggerla. Grazie