Architettura e liturgia. Piccola ricerca sulle cause di adeguamenti inadeguati
Capita spesso (purtroppo) di trovarsi in chiese in cui non ci si trova a proprio agio sia riguardo alla celebrazione liturgica, sia nella preghiera personale. Si tratta di chiese ‘non adeguate’, non soltanto dal punto di vista estetico-formale (pur importante), ma anche – e più profondamente – da un punto di vista rituale e religioso, e quindi anche architettonico-liturgico. Ma può capitare, al contrario, di trovarsi in chiese che sono luoghi bellissimi, ma che non sanno di liturgia.
Occorre domandarsi quali siano le ragioni di questo fenomeno.
Al fondo credo possa esserci, sia da parte dei committenti sia da parte degli architetti, una triplice forma di “disperazione” riguardo alla liturgia che, mutuando da La malattia mortale di Kierkegaard, potremmo descrivere così: 1) non avere coscienza del valore integrale dell’architettura nell’atto liturgico; 2) disperatamente voler mantenere completamente immutato l’assetto liturgico; 3) disperatamente voler cambiare tutto nell’assetto liturgico.
- Non avere coscienza del valore integrale dell’architettura nell’atto liturgico. Questa forma di disperazione è quella più sottile e credo sia quella più estesa e, in realtà, consustanziale alle altre due forme di disperazione.
Lo spazio, l’architettura non vengono interpretati come aspetti integrali dell’atto liturgico, ma costituiscono uno sfondo, come una sorta di scenografia, dentro cui la liturgia viene celebrata. Secondo questa visione, l’architettura certamente può influire sulla celebrazione, ma il rapporto con la liturgia è estrinseco, il fine soprattutto funzionale.
Similmente, si può assistere a un fenomeno di segno opposto, ma di uguale natura: l’architettura tende a saturare il vissuto liturgico, ossia, secondo questa visione, si tende a far concentrare nella sola architettura tutta l’esperienza religiosa. In questo caso si tratta di un estrinsecismo per il quale cui la liturgia è ininfluente o indifferente nell’esperienza religiosa. Il sacro sta tutto nell’architettura (questo spesso produce o presuppone una sorta di [auto]santificazione dell’architetto).
- Disperatamente voler mantenere completamente immutato l’assetto liturgico. La liturgia, esattamente come la fede, è vitale, e quindi non è mai statica, immutabile, ma per vivere ha bisogno di crescere, di modificarsi, di adattarsi, restando comunque sé stessa, anzi il cambiamento serve a mantenere la sua natura. Nella storia, la liturgia e insieme la comprensione della fede cristiana non hanno mai cessato di aggiornarsi, di adattarsi al momento storico: questo è il processo vitale del cristianesimo.
Tale modificazione vitale è legata alla doppia fedeltà del cristianesimo (e di ogni religione, ma per il cristianesimo vale in maniera del tutto evidente), ossia la fedeltà all’umano e al divino. Quanto all’umano, le culture (ma anche la vita di ogni singolo uomo) non sono mai state uguali a sé stesse, sono sempre cambiate le visioni, i costumi, le economie, le tecnologie ecc.: mutando quindi il “lato umano” del rapporto religioso, anche la comprensione della vita religiosa (compresa quella rituale) ha richiesto e sempre richiede degli adattamenti. Quanto al divino, esso è inesauribile e incommensurabile e, pertanto, dal momento che non può esserci una conoscenza umana definitiva del divino, per questo motivo esso richiede all’umano e al mondano un adattamento che mai si conclude. Anche guardando al “lato divino” l’adattamento è inevitabile. La fede, quindi, prevede necessariamente una sua vitale e organica modificabilità e adattabilità. Vitalità che mette in evidenza l’origine e la natura performativa, ovvero liturgica, della fede cristiana.
La disperazione di chi vuole mantenere immutato l’assetto liturgico nasce dall’incomprensione di questo processo vitale. Si pensa al cristianesimo come a una dottrina normativa per il pensiero e per l’agire e, in quanto tale, immodificabile. La liturgia rientra, in questa visione, tra le norme, la sua forma soltanto tra rubriche da rispettare per rendere l’atto di culto lecito e valido; pertanto, ogni adattamento viene interpretato come un tradimento. Secondo questa visione, la bontà dell’atto liturgico non sta nel compiere pienamente un atto che mette in relazione l’uomo con Dio, ma nell’assolvere a un obbligo, a cui Dio risponde in seconda battuta con il dono della sua grazia. Si dispera che l’atto liturgico, in quanto tale, sia contatto e unione tra la vita divina e quella umana, perché questo contatto avverrebbe in un altro luogo: nell’intimità dell’animo. Per questo motivo la liturgia (e l’architettura liturgica) possiedono una natura legale, sono obbligazioni, che hanno sì lo scopo di predisporre al dono della grazia, ma tuttavia la liturgia resta estrinseca all’esperienza di grazia.
- Disperatamente cambiare tutto nell’assetto liturgico. Questa forma di disperazione è segnata dallo stesso razionalismo della disperazione precedente. Non ci si lascia guidare dalla doppia fedeltà umano-divina e dalla natura performativa della vita liturgica e di fede, ma, partendo dalla propria visione della fede, si plasma radicalmente tutto. Se la disperazione “conservativa” pensava al cristianesimo come a un monolite immutabile, questa forma di disperazione lo pensa come a un astratto senza genesi e senza origini; in entrambi i casi si difetta nella accettazione della natura storica della liturgia, della fede e della Chiesa. La disperazione di voler cambiare radicalmente tutto manifesta, a un tempo, la difficoltà ad accettare il passato con gli errori che inevitabilmente ha portato e insieme la pretesa di essere una nuova origine, un inizio vero: è la disperazione della propria origine storico-umana e la disperazione che il divino abbia potuto accettare di offrirsi nonostante gli errori umani.
Sono forme di disperazione, sono forme di una malattia “per la morte” della liturgia e della fede.
È possibile superarle, riscoprendo la liturgia (e l’architettura liturgica che le è integrale) quale luogo fondamentale della vita religiosa. Questo può essere decisivo non soltanto per la Chiesa, ma anche per la società e la cultura contemporanee. In gioco, infatti, non c’è soltanto la vita del cristianesimo, ma la complessità della cultura umana.
Da quanto è emerso dalle recenti scoperte archeologiche sembra che con buona probabilità l’architettura rituale abbia preceduto persino quella abitativa. Senza entrare nel merito di una antecedenza cronologica, sarebbe comunque possibile riconoscere una priorità assiologica dell’architettura religioso-rituale.
Quando M. Eliade vuole descrivere il proprium del fenomeno religioso introduce innanzitutto la categoria di ‘scala’:
La scienza moderna ha riabilitato un principio gravemente compromesso da certe confusioni del secolo XIX: la scala crea il fenomeno. Henri Poincaré si domandava, non senza ironia: “Un naturalista, che avesse studiato l’elefante esclusivamente al microscopio, potrebbe credere di conoscerlo in modo sufficiente?” […] un fenomeno religioso risulterà tale soltanto a condizione di essere inteso nel proprio modo di essere, vale a dire studiato su scala religiosa. Girare intorno al fenomeno religioso per mezzo della fisiologia, la psicologia, la sociologia, l’economia, la linguistica, l’arte, eccetera, significa tradirlo e lasciarsi sfuggire appunto il “quid” unico e irriducibile che contiene: il suo carattere sacro.[1]
Questa fondamentale osservazione sul fenomeno religioso vale anche per l’architettura liturgica: essa non è da intendere come architettura che assume dalla religione elementi, contenuti, immagini ecc., ma non è neanche soltanto espressione architettonica di una esperienza religiosa.
L’architettura liturgica è un originario, appare già come un tutto organico: quando l’esperienza religiosa accade, un genere di spazialità specifico viene costituito (lo spazio sacro) ed è in quel momento che l’architettura liturgica si manifesta.
In altri termini, l’architettura liturgica non è interpretabile alla maniera delle definizioni della logica aristotelica: architettura – genere prossimo, e liturgica – differenza specifica. L’architettura liturgica, invece, è un genere a sé. L’architettura liturgica o viene praticata a partire dal vissuto religioso o non è.
E se la liturgia è rito, allora l’architettura liturgica è anch’essa rito: l’architettura liturgica, infatti, è un modo del ‘fare’, è poiesis, ed è ‘poiesis rituale’, religiosa e simbolica. Una poiesis dell’architetto che vive e progetta e una poiesis della Chiesa che celebra in quel luogo e che, in un certo senso, celebra quel luogo (in quanto simbolo esso stesso dell’incontro con Dio).
Siamo così ricondotti all’osservazione di Eliade, non è una precedenza ‘quantitativa’, si tratta di una precedenza riscontrabile in ordine alla ‘scala’ di riferimento. Soltanto a una distanza ‘religiosa’, a una ‘scala rituale’, l’architettura liturgica può essere praticata e fruita.
Fare architettura liturgica significa, innanzitutto, osservare con occhi istruiti religiosamente e ritualmente: non si tratta di volgere lo sguardo a un ambito specifico. Si tratta di guardare e soprattutto di sperimentare la realtà con occhi religiosi e di vederne compiersi la trasfigurazione.
Questo processo è una strada forse lunga, ma credo sia l’unica per poter recuperare un ‘luogo’ della vita umana decisivo e fondamentale. Girolamo Pugliesi
[1] M. Eliade, Trattato di Storia delle Religioni, Boringhieri, Torino 1976, p. IX.





























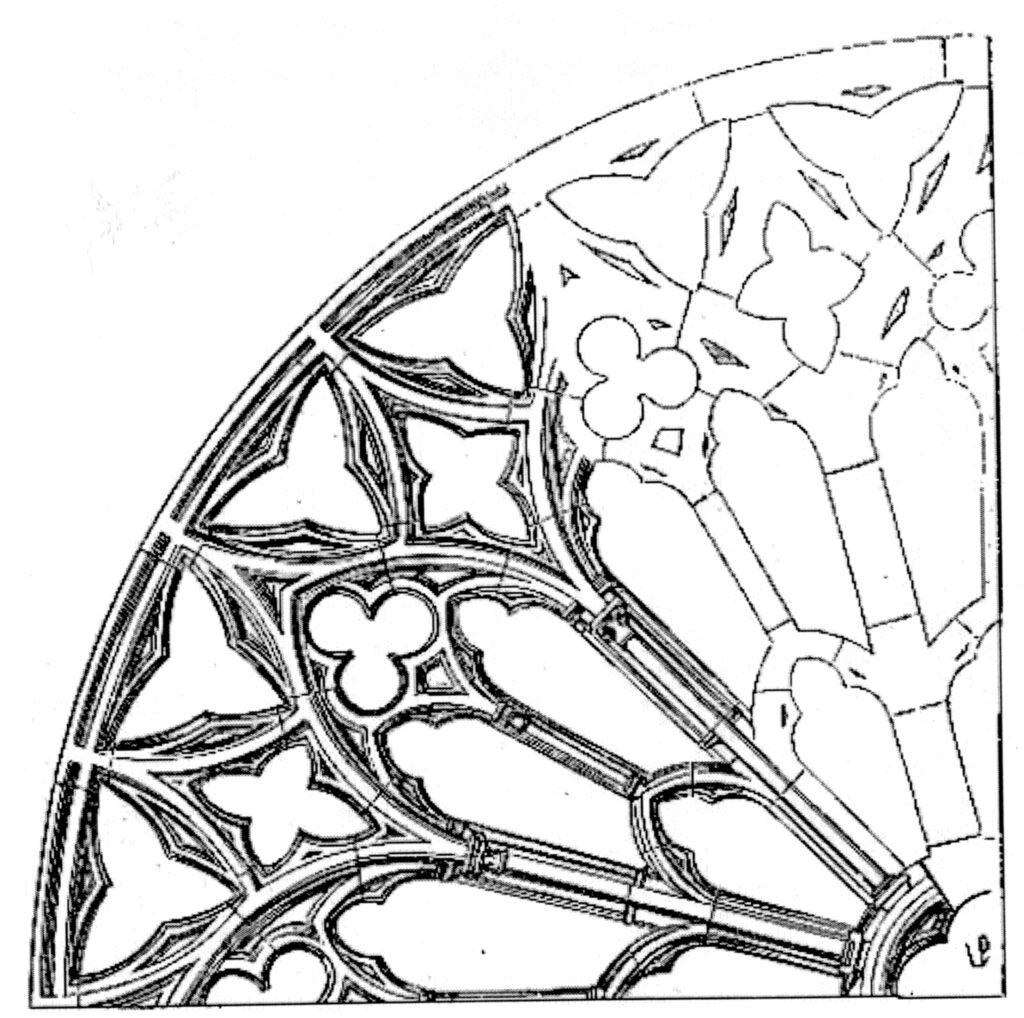
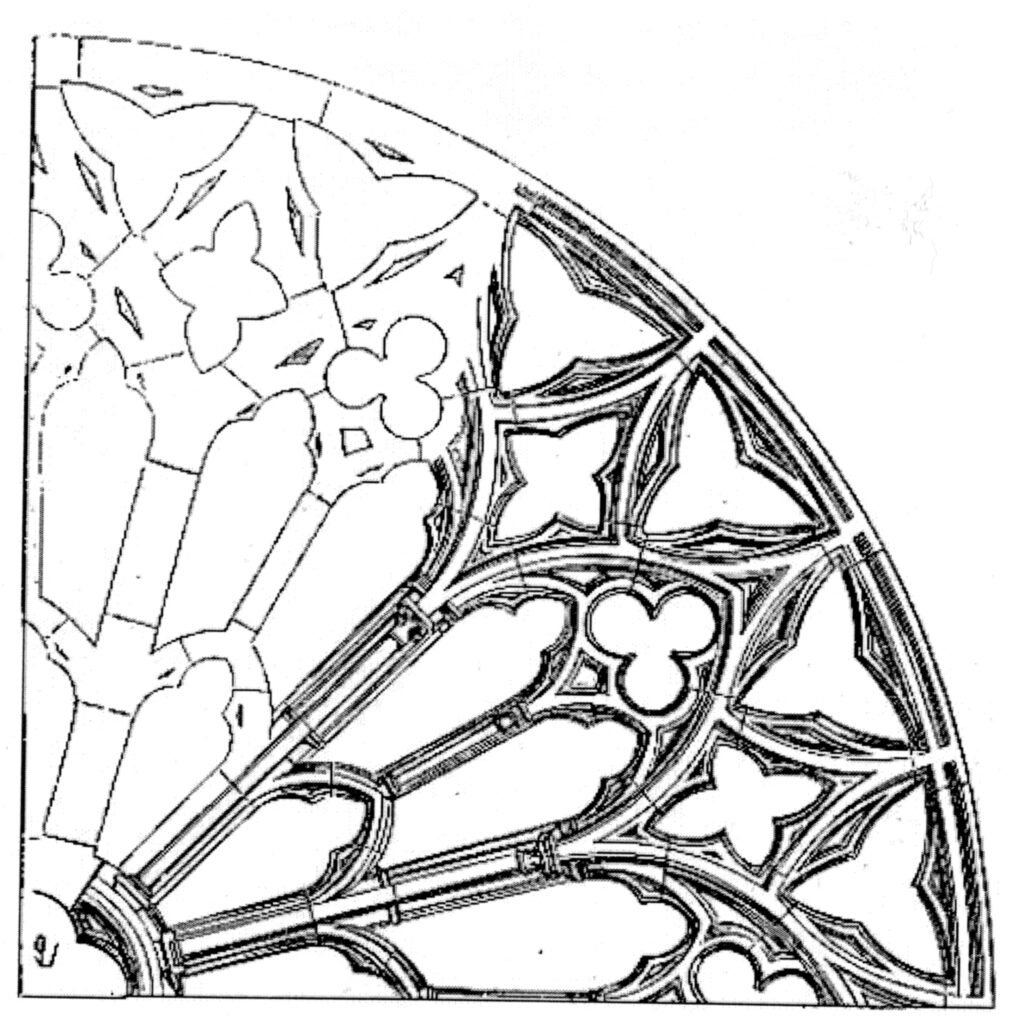
 Area personale
Area personale











